I giorni della raccolta li passavamo tutti insieme nei campi della nonna, e tutti insieme si faceva la passata. Ci ripenso sempre al supermercato e vedo la conserva stipata in bottiglie simili a quelle che usavamo.
Ci trovavamo al casale, che galleggiava sull’ondeggiare delle colline, e dietro di esso c’era un orticello dove la nonna coltivava quello che le serviva per vivere. Come il supermercato, l’orto era organizzato a file in cui le pianticelle crescevano a coppie, distanziate solo da qualche metro di terra. In fondo c’erano le melanzane, seguite dagli zucchini la cui pianta si estendeva come una ragnatela tutt’attorno, con i tronchetti verdi a formarne i raggi. Poi le patate: andavano raccolte solo una volta che le foglie s’erano seccate e la pianta sembrava morta. L’equazione era semplice: una vita, quella della pianta, per un buon raccolto. Infine, c’era la fila di pomodori, i cui rametti teneri aderivano alla stecca di bambù che usavamo per farli crescere retti: la pianta si arrampicava, primate, lungo il legno salendo verso il sole e, in cambio di un buon clima, restituiva i frutti.
La raccolta si teneva in agosto, solitamente coinvolgendo tutta la famiglia. Persino quei rami più lontani, i cugini distanti di vari gradi, arrivavano ad aiutare. Veniva anche una mia cuginetta, da sempre molto carina. Una bellezza di campagna, si potrebbe dire: il viso le tondeggiava attorno al mento e la pelle, sempre lucidissima, andava a incresparsi all’altezza delle labbra quando sorrideva. Lo faceva solo a bocca chiusa, ma questo suo modo di boicottarsi il riso non riusciva comunque a nascondere il piccolo incisivo storto, che invece faceva puntualmente capolino e si esponeva sul labbro inferiore. I capelli bruni scrosciavano, onda dopo onda, fino ad allagarle le guance, e facevano da cornice a quegli occhietti piccini e verdissimi, come lo stelo di una pianta di pomodoro. Era di qualche anno più piccola e ogni volta che mi ronzava attorno mi sentivo attirato, come se la sua pelle fosse un magnete, dal suo profumo o anche solo da quel suo modo di camminare a papera, con i piedi aperti verso l’esterno. Ero stato io, la prima volta, a proporle di baciarci. Per lei era un gioco, ma per me era l’unico sfogo a quella voglia tremenda di farmi animale e toccarla: fremevo a ogni nuovo agosto per l’arrivo di quei giorni di lavoro.
La giornata prevedeva fasi scandite dalla posizione del sole sulle nostre teste e dall’altezza delle nostre ombre. Quando erano più lunghe a sinistra, se rivolti verso il campo, significava che era il tempo di disperdere i bambini nell’orto alla ricerca di quelle gemme rosse che penzolavano dal verde.
Intanto si accendeva un fornello largo, di quelli da esterno, e si metteva a bollire qualche gallone d’acqua in un calderone d’alluminio. A noi bambini non era nemmeno permesso di avvicinarsi al pentolone e, nel caso fosse successo, ci venivano riversate addosso le ire dei genitori: temevamo più questo, le grida del papà, della mamma o addirittura della nonna o degli zii, che le fiamme e le ustioni.
Finita la raccolta, solitamente quando il sole formava una pozza d’ombra nera sotto ai nostri piedi, si procedeva con il lavaggio e con la bollitura dei pomodori. L’addetta era la nonna nascosta dietro al vapore mentre, come una fattucchiera, con la pala calmava il bubbolio frenetico che si agitava nel paiolo. L’ultima parte, la spremitura, era opera degli adulti. Noi bambini sporcavamo troppo e solitamente usciva più passata dai vasetti di quella che ci entrava. I cugini più grandi allestivano con gli zii un tavolo per la merenda: fette di salame fatto con la carne dei maiali del nonno e parmigiano a scaglie, e si beveva lambrusco poco fermentato, così che rimanesse dolce e non fosse troppo alcolico.
Una di quelle mattine, quando io avevo tredici anni e lei non più di una decina, mia cugina era arrivata prima di me. Entrato nel casale, lei era già bardata di stivali e guanti troppo grandi per le sue mani.
«Arrivi sempre dopo di me, anche nella raccolta», aveva ridacchiato.
«Vedremo oggi», le avevo risposto con il tono dei personaggi dei cartoni animati.
Dopo essermi cambiato a mia volta, stivali sporchi dall’estate precedente e guanti da gigante indosso, eravamo usciti alla volta del campo. Ci si era stagliato di fronte una distesa quasi infinita, con una decina di file di pomodori. L’orto si allungava e si curvava trascinato dal versante della collina su cui il casale, come un tempio, contemplava la valle. Mia cugina si era precipitata verso l’orto senza la paura di scivolare, anche se ogni anno, periodicamente, cascava e tornava in casa a disinfettarsi. Quando le disinfettavano le ferite con l’acqua ossigenata, ne sentivamo le grida fin nel campo: noi coperti di sudore salato, lei di quell’acqua così tossica che la faceva urlare di fastidio. Poi tornava, con l’occhietto rosso e lucido, ma con il solito dentino che spuntava dalle labbra.
Arrivata fra le file, s’era subito messa a cercare, senza nemmeno aspettare che la raggiungessimo: «Via», aveva stridulato, «a chi ne trova di più entro la bollitura».
Eravamo cinque nipoti in totale, e le file erano divise in modo da averne due a testa e chiunque a mezzogiorno avesse raccolto il peso maggiore di pomodori, era proclamato vincitore. Mia cugina partiva sempre dalla terza fila; io, invece, dalla prima. Subito il mio sguardo l’aveva persa tra le pareti di pomodori, come fosse un pezzo di quel nostro museo dell’infanzia, e il mio occhio fosse così abituato alla scena da non vederla più: cieco, ma solo di fronte a lei. Anche se di tempo ce n’era, e fosse più importante essere meticolosi che veloci, lei s’affannava nel raccogliere i pomodori, come se si aspettasse che ricrescessero nel tempo in cui lei si dedicava all’altra fila, così da tornare su quella precedente e raccogliere i nuovi cresciuti.
A mezzogiorno, sole perpendicolare su di noi, la nonna aveva gridato che l’acqua bolliva e aveva decretato la fine della gara. Mia cugina era venuta di fianco a me, spalleggiandomi, e guardando nel mio cestino quanti pomodori avessi raccolto.
«Vedremo al paiolo», aveva detto prima di rimettersi a correre.
Al casale, i genitori e gli anziani, colossi, erano disposti intorno al pentolone, seduti su sedie di plastica che si incurvavano sotto al peso di quei giganti. Solo la nonna stava ritta di fianco al fuoco, reggendosi sulla pala che usava per mescolare: come in un processo, la strega stava al centro, affianco al fuoco, e i giudici tutt’intorno.
Era seguita la pesa: da una bilancia con il braccio penzolava un piatto arrugginito su cui avevamo posato i nostri pomodori, uno per uno, vittime sacrificali. Io ne avevo raccolta una trentina, tra piccoli e grandi, ma mia cugina aveva raggiunto un peso maggiore: vincitrice, di nuovo. Si era girata a sorridermi, con gli occhi del centometrista arrivato primo che, dopo il traguardo, si volta a guardare arrivare il secondo. Poi aveva ricominciato a correre, soddisfatta, con gli altri ragazzini. Nel frattempo, uno zio aveva aiutato la nonna a tuffare i pomodori nell’acqua. Appena buttati, si muovevano come bolle, come si impasta la lava e il magma, mentre l’acqua, spillata fuori a goccioloni, seguiva le traiettorie dei fiumi vergini alla ricerca del mare: il calderone come una Terra primordiale; noi, dèi in miniatura, assistevamo al susseguirsi degli eventi che avrebbero portato alla nascita della vita.
Contenta più delle altre volte, mia cugina correva nei d’intorni e si fermava ogni tanto al tavolo del cibo. Lì rubava qualche fetta di salame, la mangiava e riprendeva la fuga. Non si era nemmeno resa conto che si stava avvicinando pericolosamente al paiolo. I grandi avevano cominciato a osservare le orbite che percorreva, graficandone nella mente le traiettorie. Per allontanarla, le avevano lanciato qualche occhiata intimidatoria, ma lei non ci faceva caso e si mostrava addirittura sorda, improvvisamente anziana, di fronte ai richiami che ogni tanto le mandavano. Alla settima rivoluzione troppo vicina alla pira, uno zio si era alzato facendo cascare la sedia all’indietro. Come un dio arrabbiato, aveva sbraitato qualche maleficio in dialetto, pietrificandola, statua, immobile sul posto. Le ombre s’allungavano verso destra quando mia cugina aveva cominciato a piangere: una regina spodestata, le cui fughe, e anche quelle di noi cugini, erano state interrotte.
Era tornata in casa a nascondersi dalla vergogna e poco dopo l’avevo raggiunta nella stanzetta dove usava dormire quando rimaneva dalla nonna. Era al secondo piano, con un lettino troppo alto per lei e con una sola finestrella quadrata al centro del muro. La stanza, così come tutto il casale, era fresca nonostante fosse agosto per via dei muri spessi in mattone che la isolavano dall’ambiente esterno. Varcata la soglia del suo regno, lei era lì, sdraiata sul letto, con strade salate a percorrerle il broncio.
Mi ero seduto di fianco a lei accarezzandole la gamba. Alzandosi da quella posa, si era appoggiata alla mia spalla. Eravamo rimasti in silenzio, abbracciati, a rubarci un po’ di calore per qualche attimo. Era ancora piccola, lo sapevo, e lo ero anche io, ma stavo iniziando a scoprire il sesso, toccandomi, latitante, ogni tanto e di nascosto. Avevo scoperto quel piacere per puro caso, vedendo due scoiattoli che si accoppiavano su un ramo. Per sfogare la curiosità, quasi come uno studio dei meccanismi della vita, mi ero masturbato appena arrivato in casa. Dal canto suo, mia cugina, con i nostri baci, era il limite della mia conoscenza: quanto di più vicino all’amore fossi arrivato.
Così, sdraiandoci uno affianco all’altra, con le mani avevo iniziato a esplorarla, percorrendo, pellegrino, monti non ancora cresciuti, mentre fra le mie gambe cresceva una piccola vetta. Quando avevo provato a toglierle i pantaloncini si era irrigidita e aveva allontanato le labbra dalle mie. Non capendo i miei gesti e non sapendo come interpretare quella danza, mi aveva chiesto di smetterla.
«Stai zitta», le avevo sussurrato succube degli ormoni, «sono io il più grande e tu devi fare quello che dico».
Non rispondendo, aveva piegato la testa verso il lato, come per non guardarmi negli occhi e non essere costretta a ricordarsi anni dopo che ero stato io il ragazzino sopra di lei: affogava, in silenzio, fra le onde che descrivevano i nostri corpi.
Si era alzata dal letto, facendo scricchiolare il pavimento di legno. Una lacrima di sangue le aveva percorso la gamba fino al calzino bianco, si era diffusa nel tessuto, allargandosi in una macchia rossa come la passata di pomodoro. China, se l’era tolto per non sporcare, prima di correre in bagno.
«Non dire nulla», le avevo intimato, «nemmeno agli altri cugini». Sullo stipite, si era girata appena e aveva risposto con un cenno.
Il giorno dopo, mentre tutti caricavano le bottiglie nelle macchine, l’avevo vista stare in piedi a fissare l’intruglio rosso dentro i vetri. Poi, presa per il braccio da suo padre, era salita in macchina salutando a bassa voce chi era rimasto. La macchina era salita per la stradina che portava alla statale e l’avevo seguita fino a perdersi nel serpeggiare della via attorno alle colline. Non immaginavo che quella raccolta, quell’estate, sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei vista. Io mi sono sempre presentato in anticipo, aspettandola, sperando che si ripresentasse e che mi chiamasse per gareggiare nel raccogliere i pomodori.
«Ormai è cresciuta, pensa ad altro», dicevano gli zii, per poi ammiccare sottovoce: «ai ragazzi».
Ma continuavo ad aspettarmi che qualcuno scendesse dai sedili posteriori della loro macchina; che saltasse, rimanesse in volo per un istante, e atterrasse con i piedi adesi a terra. Come la bottiglia di passata che prendevo sempre, quella con lo stesso vaso che usava la nonna, e che, bambina, gridava un tintinnio cadendo nel carrello a ogni mia spesa.
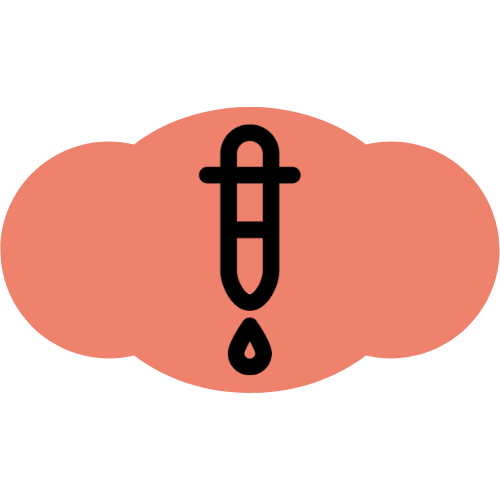 Fabrizio Pelli è nato il 29 giugno 2001 a Reggio Emilia. Suoi lavori sono apparsi su varie riviste letterarie. È stato selezionato tra i venticinque semifinalisti del Premio Campiello Giovani 2022. Fa parte della redazione della rivista letteraria Enne2 e di Super Tramps Club.
Fabrizio Pelli è nato il 29 giugno 2001 a Reggio Emilia. Suoi lavori sono apparsi su varie riviste letterarie. È stato selezionato tra i venticinque semifinalisti del Premio Campiello Giovani 2022. Fa parte della redazione della rivista letteraria Enne2 e di Super Tramps Club.
