I giorni di torneo papà ha una faccia specifica. Se ne sta lì a guardarmi teso e solenne come se avessi da compiere una grande impresa, ma allo stesso tempo insoddisfatto come se già sapesse che non succederà. Se per caso mi dimentico che quello è un giorno di torneo, mi basta guardare in faccia lui per ricordarmene.
Passo lo spazzolino in verticale e poi in orizzontale, mi ispeziono le gengive, cerco di metterci più tempo che posso. Mi guardo anche negli occhi, ma solo per un attimo, per via di quel certo imbarazzo che mi provoco. Apro la porta del bagno senza far rumore e sguscio fuori a passi lenti, sempre più piccoli, sono quasi ferma. Il corridoio è un’autostrada e io la percorro a piedi, ci vorranno anni per arrivare in cucina. Ci arrivo comunque poco dopo.
Papà è seduto lì, i gomiti sul tavolo, gli occhi nella tazza vuota. Mi guarda e ha esattamente quella faccia, così preso dai suoi conflitti che evito di salutarlo per paura di disturbare. Accenna con la testa alla scodella di riso soffiato e latte che ha preparato per me. Osservo i chicchi spugnati galleggiare nel liquido immobile e senza produrre alcun rumore inizio a ingurgitare cucchiai sotto i suoi occhi. Il suo naso grugnisce nel silenzio ogni volta che tira su aria.
«La strategia è questa», esordisce solenne, occhi sbarrati, collo rigido.
Ingoio la poltiglia senza masticare, con la bocca aperta per non sentirne la consistenza.
«L’avversaria è molto più alta di te, questo le dà un vantaggio. Ma noi dobbiamo concentraci sui punti deboli. Per tua fortuna, io la tua avversaria l’ho studiata bene. Il suo punto debole sono gli spostamenti laterali.»
Respiro a fatica, come se i miei polmoni diventassero più piccoli ogni volta che prendo aria. Eppure sento di occupare molto più spazio di quello che mi spetti.
Papà inizia a oscillare il dito in aria davanti ai miei occhi. Destra sinistra, destra sinistra.
«Significa che la devi spostare da una parte all’altra del campo, tipo tergicristalli, ci sei?»
Destra sinistra.
«Tutti pallettoni, sia chiaro, non puoi mica diventare la Sharapova all’improvviso.» Fa una pausa lunga e studiata. Io annuisco profondo.
«Ma puoi farla diventare matta, questo sì. Quelle come te, a quelle alte così, le fanno diventare matte, hai capito? Lei avrà il fisico, ma noi abbiamo la testa», mi fissa da vicino, quasi m’infilza le pupille con gli occhi. La sua faccia significa che la mia reazione non lo soddisfa.
«Si può sapere cos’è quell’aria da pesce lesso? Cattiva devi essere, grinta, capito?»
Faccio uno sforzo immane per trovare lo sguardo giusto, quello che lo faccia smettere di parlare.
«Vai a vestirti», lo sento dire infine con una specie di rassegnazione, mentre torna finalmente alle sue cose.
Chiudo la porta della mia stanza e per un attimo penso che posso respirare. Poi mi volto. I mobili bianchi lucidi, gli scaffali dei libri, la carta da parati con i palloncini. Unica imperfezione, sull’anta immacolata dell’armadio, il piccolo foro che risale a quella volta in cui ho appeso il poster di Kavana. Non sapevo chi fosse Kavana, ma Carlotta non lo voleva, così l’ho portato a casa e l’ho attaccato all’armadio con una puntina da disegno. Il giorno dopo al ritorno da scuola il poster non c’era, ed era come non fosse mai esistito, non fosse stato per il minuscolo foro. Papà non ha mai detto nulla al riguardo. Non l’ho fatto nemmeno io.
Il terzo cassetto dal basso è quello dei completi da torneo, che papà sistema in ordine di colore, bianchi, neri e blu. Afferro il primo completo bianco e me lo infilo piano per non sgualcirlo, mi sento anche in colpa perché non ci riesco. Apro l’anta dell’armadio per guardarmi allo specchio, ma la richiudo subito.
Nei pochi metri cubi d’aria dell’abitacolo le parole lente e cadenzate di papà mi esplodono in testa, una dopo l’altra, come bombe. Grinta, ripete, cattiva, e si mangia tutto l’ossigeno. Più lui lo ripete, più io divento debole e flaccida. Papà fissa la strada, tiene le mani alle dieci e dieci, si ferma col giallo, non supera i limiti di velocità. Eppure so dalla sua faccia che questo è quel momento in cui si chiede perché perda ancora tempo con i miei tornei, visto che non vinco mai.
Elena Torrisi, per qualche scherzo malefico di Dio o chi per lui, è alta, magra e bionda. Sguaina la racchetta con una disinvoltura magnifica e inizia a saltellare di qua e di là controllando la tensione delle corde con sicurezza. La coda di cavallo oscilla da una parte all’altra come il gonnellino rosso, che scopre ogni volta due gambe lunghe e lisce. Mi dirigo verso la mia parte del campo come una condannata a morte. Iniziamo il palleggio di riscaldamento e lei sfodera colpi perfetti, eleganti, che mi affanno a rimandare come posso. Il fatto è che non solo è più alta di me, è più forte e più brava, e tira palle lunghe e pesanti che riesco a malapena a respingere. Proviamo i servizi, poi è il momento di iniziare. Papà sta seduto in fondo agli spalti con gambe e braccia incrociate, la bocca serrata. Non appena incontra il mio sguardo mi rivolge il pugno chiuso mostrandomi i denti. Grinta, dice senza voce, cattiva. Annuisco e vado a servire, pregando di metterla dentro.
Servo una prima debole e lei colpisce un dritto incrociato profondo che sfioro appena. La palla finisce sul muretto laterale del mio campo. Zero quindici. Questa volta metto una prima decente sul suo rovescio, ma lei risponde con una palla lunga e alta che respingo come posso, allora entra di diritto e incrocia forte vicino alla riga. Non la vedo neppure, zero trenta. Percepisco alla mia sinistra la sagoma di papà che cambia posizione senza tregua. Torno a servire, ma il braccio mi trema visibilmente e commetto doppio fallo. Papà allarga le braccia e fissa un punto indefinito all’orizzonte, ma che cazzo, decifro sulle sue labbra. Il servizio successivo lo metto dentro, ma prima che possa capire che succede lei esegue una smorzata perfetta. È uno a zero. Elena trotterella sicura verso il cambio campo mentre io mi sforzo di non piangere. Mi siedo e bevo a sorsi piccoli, lei ride con le sue compagne a bordo campo. Grinta, cattiva, mi ripeto poco convinta tornando in campo. In pochi minuti sono sotto sei a zero.
Cambio campo con la sensazione di avere una nuova chance: in fondo ogni nuovo set lo è. Siamo di nuovo zero a zero, devo convincermi di questo, anche se papà è scivolato in avanti sulla panca e se ne sta lì con la guancia appoggiata alla mano, e lo sguardo che vaga lontano da me. Ma io sento che questa volta qualcosa mi è scattato dentro. Mi metto in posizione per ricevere mentre Elena fa rimbalzare la palla per terra, una, due, tre volte. Noto un eccesso di sicurezza in lei, giurerei che nasconda qualcosa di simile alla paura, deve aver percepito il mio cambiamento. Lancia la palla in aria, carica col braccio e colpisce. La palla finisce in rete e rotola indietro nel suo campo. Mentre si appresta a servire la seconda, io avanzo di un passo pronta a sorprenderla. Elena serve una palla morbida, che mi rimbalza vicino ai piedi. Avverto allora un fremito, una specie di fame che mi pervade tutta. Vado incontro alla palla ed entro con un dritto potente e incrociato che schizza via davanti ai suoi occhi. Non credevo di essere capace di un colpo simile. Avverto una sensazione mai provata prima: la vita è bella ed è capace di sorprendere. È zero quindici. Per la prima volta dall’inizio del match sono in vantaggio, solo di un punto ma pur sempre in vantaggio. Papà sembra aver ripreso vita sugli spalti, ha la schiena dritta, lo sguardo proteso. Mi fissa con occhi vivi e mi mostra il pugno: «Grinta!», grida, «cattiva!».
Annuisco lenta, persa negli occhi di papà come davanti all’orizzonte. Ci credo. Mentre raggiungo il lato sinistro del campo mi sento forte come non credevo di potermi sentire. Grinta, cattiva, mi ripeto.
Elena è già pronta, con la mano sinistra fa rimbalzare la palla per terra, una, due, tre volte, il corpo in avanti, decisa a farmela pagare. La palla si solleva in aria, Elena con grazia felina carica il braccio e poi spara la racchetta verso l’alto. Colpisce una palla che pare un fulmine, sento solo un tonfo dietro di me. Ace. Quindici pari. Papà non si muove di un millimetro, ma dopo un lunghissimo istante si gira e mi guarda. Grinta, mi fa. Annuisco, e quasi senza respirare vado a rispondere. Elena è pronta a servire, questa volta non fa rimbalzare la palla per terra tanto ha fretta di iniziare lo scambio. Mette una prima potente, io riesco a rispondere ma all’improvviso me la ritrovo a rete, dove colpisce al volo chiudendo dall’altra parte. La sua amica sugli spalti ride applaudendo forte, Elena le dice qualcosa con complicità. È tutto un gioco tra loro, io non esisto.
Papà si alza di scatto, rosso in volto, poi si blocca, infine si abbandona alla panca con occhi vuoti, quelli del ritorno alla realtà. Elena si prende il game in pochi minuti senza lasciarmi giocare. Al cambio campo mi siedo in panchina con la sensazione che sia già tutto tornato come prima. Papà muove il busto ritmicamente avanti e indietro in un gesto autoconsolatorio, con gli occhi fissi di un bambino deluso. Elena beve senza nemmeno sedersi, ha fretta di vincere e tornarsene a casa. Io cammino verso il mio lato del campo senza pensare a niente, senza dirmi niente, non mi importa più di niente. Però nel momento in cui incrocio Elena la guardo in faccia. Lei no. Lei punta il campo davanti a sé come un cowboy il terreno di scontro. Non si distoglie dall’obiettivo preciso e limpido di vincere, nonostante il vantaggio schiacciante e la sua superiorità indiscutibile. Grintosa e cattiva, è esattamente così, come io non riesco a essere.
Allora mi sale tutta insieme una cosa dentro. Mi fermo, mi volto. Elena è già in fondo al campo, china ad allacciarsi le scarpe. Cammino spedita verso di lei finché non le sono alle spalle. Il sole scintilla tra i suoi capelli biondi, che raccolti nella coda le ricadono fluenti sulla schiena. Sollevo lentamente la racchetta sulla mia spalla come per eseguire un servizio, ma col piatto corde girato di taglio. Mi concentro anche sulla tecnica: inarco bene la schiena e tengo il gomito basso. Poi slancio il braccio con tutta la forza che ho in corpo. Neanche sapevo di averne tanta. È un suono sordo, un colpo secco. Grintoso e cattivo. Tra i capelli di Elena compare una macchia rossa che brilla nel sole, poi si allarga in fretta fino a invaderle tutta la testa. Elena cade in avanti, la fronte sulla terra rossa, poi si rovescia di lato. Urla dagli spalti, gente che entra in campo.
Io cerco avidamente lo sguardo di papà ma lui se ne sta lì a fissare il vuoto, tutto sommato con una faccia che non gli ho mai visto prima.
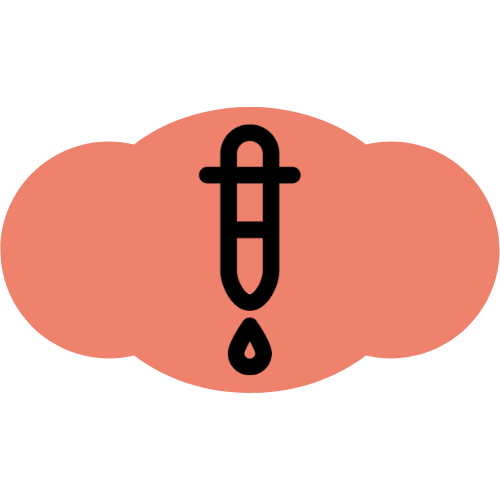 Valeria Sirabella, 38 anni, è laureata in giornalismo e ha un master in relazioni pubbliche. Ha lavorato tra Roma e Milano in pubblicità e comunicazione aziendale. Un paio di suoi monologhi teatrali sono stati messi in scena da Massimiliano Bruno durante lo spettacolo Paspartù; suoi racconti sono apparsi o appariranno su Carie, Risme, Crack. Per tre volte ha raggiunto le fasi finali del concorso 8×8 si sente la voce, di Oblique studio.
Valeria Sirabella, 38 anni, è laureata in giornalismo e ha un master in relazioni pubbliche. Ha lavorato tra Roma e Milano in pubblicità e comunicazione aziendale. Un paio di suoi monologhi teatrali sono stati messi in scena da Massimiliano Bruno durante lo spettacolo Paspartù; suoi racconti sono apparsi o appariranno su Carie, Risme, Crack. Per tre volte ha raggiunto le fasi finali del concorso 8×8 si sente la voce, di Oblique studio.
