Jahir si aggira col suo bel turbante bianco per le strade di Roma, impettito come un pavone. Una volta scattava polaroid ai passanti come i suoi compagni, amici per forza di cose – non che fossero uno spasso, ridevano per cose banali, lui si sforzava per educazione.
Una comunità così forte da legare i bengalesi a rimanere tali, a rimanere con uno smanicato anti-vento e con dei jeans scuri. Jahir detesta i jeans. Il lino, il cotone, quelli sono tessuti. Se ne va per la sua via impettito col turbante e i pantaloni di lino, freschi e radiosi come il sole in agosto. Una tracolla di cotone per portarsi appresso olio, creme varie e un tablet, che – eccezion fatta per album costituiti esclusivamente da foto di fiori – serve a mettere una musica adatta a rilassare i suoi clienti. Su YouTube ha trovato la chiave giusta per accompagnare armoniosamente le sue dita sulla pianta del piede italico con grazia e decisione, come fosse una massa d’argilla da plasmare.
Il Kuringrham è qualcosa di più di un ricordo, ma niente in confronto al suo bel turbante bianco. A pensarci bene, era tutto così uguale, lì. Paludi, baracche, fango, mura; spostarsi da un isolato all’altro significava tornare al punto di partenza, in pratica. Era come essere in quel gioco che tutti, qui, conoscono e ricordano con nostalgia, quello con l’omino giallo che esce dal bordo destro dello schermo per sbucare dal sinistro, all’infinito. Jahir ha giocato a una versione molto simile sul suo telefono qualche volta.
Jahir ha sempre avuto l’ambizione di essere indiano, esserlo abbastanza da sembrarlo agli occhi degli altri. Sopratutto agli occhi degli altri. Sogni troppo ingombranti per il Bangladesh, che poi è una Nazione immensa, ma talmente cosparsa di gente da rendere difficile trovare lo spazio necessario a incasellare qualcosa di più di una manciata di parole.
Rosalba è una donna pingue, accogliente e morbida come le sue forme, una donna che è quel che appare verrebbe da dire. La sua più vecchia cliente, la più fedele e generosa. Una casa troppo grande, a ogni modo, persino per quei piedi gonfi. Piedi che grazie alle sue dita ammaestrate diventano via via sempre più umani. La pelle della donna si ammorbidisce a ogni passaggio. L’olio viene assorbito dalla pelle di entrambi, un legame davvero sentito da Jahir, anche se non compreso fino in fondo.
La musica fa danzare le note nelle orecchie totalmente assuefatte della donna, la quale si rilassa e forse anche lei, fosse anche solo per un attimo, passa finalmente dall’altra parte di quel muro. Jahir si chiede da sempre che genere di muro vogliano superare i vari clienti, ma ancora, dopo quasi tre anni di attività, non ha sviluppato una fantasia tale da immaginare, da lasciare andare i suoi occhi all’indietro per darsi uno sguardo dentro. Che pensiero audace, profondo.
Tutta colpa della signora Clelia e delle sue incomprensibili poesie. Il trucco è fingere di non capire l’italiano, tutto poi fila liscio.
Impietosa si espande l’orda di carne viva tutt’intorno. Sembrerebbe qualcosa di orripilante.
Il caldo rende tutto più astruso e bagnato.
Alla morte di un sovrano si esulta, alla morte di un servo… della morte di un servo non si dovrebbe aver modo di parlare, mai, tra la gente per bene.
Fiori che sono tanti, come le persone, che sono variegati, come le persone e il gelato, che sono belli anche da morti, non come le persone… ma non si può nemmeno pretenderlo.
I fiori, a ogni modo, sono brave persone. Jahir si perde sempre in pensieri senza capo né coda quando la cliente si lancia in lunghe interpretazioni dei suoi scritti. Non gli piace perdersi.
«Brava signora Clelia, grazie.»
Jahir è un finto indiano, ma educato.
Quando si ritrova, suo malgrado, a una manciata di passi dal palazzo di Clelia, si mette a osservare l’imponente edicola della Madonna, all’angolo dell’edificio. Un indiano… sì, deve essere per forza un indiano, porta il turbante; un indiano che guarda la Madonna. E pensa. Che scena pittoresca… questo sicuramente bisbiglia la gente osservandolo distrattamente; per lo meno i più sensibili.
Clelia è una donna allegra, ma ha un naso severo che sciupa tutto, ogni volta. Jahir la guarda e sorride subendone la gioia e la grazia, poi la guarda meglio e non si sente più tanto a suo agio. Colpa del naso. Se Jahir avesse il suo naso e i suoi soldi certamente se lo farebbe aggiustare, il massaggio ai piedi sarebbe l’ultima delle preoccupazioni. Ma dopotutto un Papavero e una Peonia non ragionano allo stesso modo. Le unghie dei piedi sono sempre curate, santa donna. Santa quasi come quella che sta appesa senza una ragione precisa all’angolo del palazzo… quella santa il naso ce l’ha grazioso però.
«L’alluce. L’alluce è tutto, signora Clelia», Jahir questo lo ha imparato seguendo delle lezioni online di un vero maestro indiano. Nell’alluce è racchiuso il flusso dell’essenza dell’uomo, l’alluce è la testa.
Arrivato a casa, prima di mettersi a cucinare, prima di selezionare le porzioni di spezie con estrema caparbietà e perizia, Jahir si toglie il turbante con devozione per riporlo rispettosamente sopra una seggiola appositamente dedicata.
Strano, quando questo avviene l’uomo si trova di colpo nelle acque putride delle paludi del suo Paese. Pensa, ricorda. Ricorda sua mamma… che bella donna. Di colpo cade dal lato sbagliato del muro, quello di partenza; di colpo il confine è ricolmo di agenti indiani pronti a denudare, bastonare e umiliare qualsivoglia sventurato. Col senno di poi, se all’epoca avesse avuto un turbante, probabilmente sarebbe entrato in India dalla porta d’ingresso, a testa alta. Che pensiero sciocco.
I turbanti sono il frutto di nove metri di tessuto, ma quello di Jahir, in realtà, è un copricapo di scena. Si toglie e si mette con comodità, come un qualsiasi berretto; la comodità è un punto importante per lui, non può permettersi il lusso di perder tempo ad attorcigliare cose sulla testa. Essere un maestro indiano è una questione di animo in fin dei conti, di questo Jahir è certo. Dopo tutto, quello, è un finto turbante realizzato a regola d’arte, fa il suo figurone.
Daulat ki chaat, un dolce squisito. Il libro di ricette è utile, chi se lo aspettava. Come sta bene quel turbante sulla sedia, sembra fatto per stare su qualsiasi materiale, dalla pelle al legno.
Una ragazza, una volta, riuscì a oltrepassare quel muro. La guardava come si guarda una tigre volare, con stupore e ammirazione, dunque. La giovane sparì dietro quelle pietre mal riposte. Poi si sentì gridare, Jahir ne ricordava ancora la paura viscerale. La bastonarono? Fecero qualcosa di più? Jahir ha sempre avuto un problema con l’immaginazione e quelle pietre non permettevano lui di dare un’occhiata a quanto stesse succedendo. Forse le guardie, sbalordite dalla bellezza di quella giovane, erano state mosse dalla meraviglia e l’avevano lasciata passare, urlando dallo stupore e dallo sconcerto. Forse vi s’erano avventati come ci si avventa su di un alligatore per sventrarlo e lei li aveva disarmati e abbattuti… era così bella; alle persone belle accadono solo cose belle, di questo Jahir è convito. Non riesce più a ricordare, però, se questo pensiero appartenga al Bangladesh o all’Italia.
Senza capelli, ma in compenso che barba folta. Pupazzi, centinaia di pupazzi, protagonisti di film fantasiosi, colorati. Pupazzi a perdita d’occhio.
«Questo è Ryuk, è il mio preferito. Guarda i dettagli del viso. È pazzesco, mette i brividi, sembra vero. Jahir lo hai mai visto Death Note? No? Amico mio devi rimediare.»
«Va bene. Grazie.»
Il pupazzo è orrendo e i piedi del barbuto sono pelosi come quelli d’un macaco e le dita di Jahir, avvezze a ben altre tipologie di piede, sembrano reticenti. Questi peli sono comunque denaro e il denaro è utile, anche se, fosse per lui, ne farebbe a meno – a cosa serve mangiare, pagare un affitto, una bolletta quando si ha un turbante così bello?
Jahir prende il primo piede con trasporto; lo cosparge d’olio. Le mani sfuggono sinuose al controllo. L’olio batte i peli.
Jahir ha sempre avuto una passione viscerale per i fiori, semplicemente perché sono belli. Ironico pensare al fatto che sia scampato al vendere rose, a lui erano toccate le polaroid – sfortunatamente per quanto lo riguardasse, anche se dopo aver scoperto da dove provenivano ne faceva volentieri a meno – non faceva altro che scaricare sul tablet fotografie di fiori, d’ogni colore e genere, specialmente di tulipani; Google per lui è prettamente questo, per non parlare della scoperta di Pinterest.
Quant’è bianco il turbante oggi. Ogni volta che lo lava non può fare a meno di stupirsi. Se ne sta qualche minuto allo specchio, tutto contento… sempre per quella storia del pavone. Quel turbante glielo aveva regalato un burattinaio di Bologna. Aveva da poco concluso uno spettacolo e Jahir, che all’epoca scattava delle splendide polaroid ai giovani avvinazzati alla modica cifra di cinque euro, non potè fare a meno di fermarsi a osservare, un po’ in disparte, quella messa in scena particolare. Gli piacque così tanto che alla fine volle andare a curiosare dietro quel baraccone. Il mastro burattinaio gli chiese una mano per smontar tutto e come ringraziamento gli regalò il turbante e un bastone da passeggio. Il bastone non s’è più trovato, il turbante, d’altro canto, è inseparabile dalla sua capoccia – a Roma dicono così, questa parola lo fa sempre molto ridere. Quando ride però non si scompone troppo, gli indiani si contengono.
Anche la santa sull’angolo del palazzo della signora Clelia ha una cosa strana in testa… non di certo un turbante però. Nei vicoli del centro storico si parla spesso di lui. Il suo numero di telefono è passato di mano in mano come fosse una moneta e in una maniera così rapida da far sentire Jahir molto orgoglioso, tanto orgoglioso da esserne imbarazzato, delle volte. Riceve almeno dieci messaggi al giorno, il che porta a riflettere, dal momento che Jahir non ha amici – dopotutto un indiano col turbante non può andare a bere con dei bengalesi e i veri indiani con i veri turbanti non possono andare a bere con un finto indiano con un finto turbante, è logico.
Da qualche settimana il passaparola ha portato un nuovo strano cliente. Porta l’uniforme, sempre perfetta, non una piega sulla camicia e proprio come lui anche quest’ultimo se ne va in giro con un copricapo. Rigido e nero, molto autorevole. Jahir la prima volta che lo ha incontrato s’è spaventato, aveva sentito dire molte cose sui carabinieri negli anni e la paura di essere arrestato per aver sfoggiato un finto turbante lo aveva tenuto sveglio non poche notti. L’uomo fortunatamente sembra via via sempre più morbido, quindi forse i carabinieri sono brave persone. Dopotutto uno con un berretto così bello non può che essere una brava persona. Per quanto se li lavi, disgraziatamente i piedi dell’ufficiale puzzano. Non si può aver tutto. Di sicuro non spetta a Jahir il compito di dirglielo, non sia mai cominciasse a indagare sulle sue origini. Ci pensasse la moglie a ragguagliarlo… ma, santo cielo, che lo faccia!
Col suo bel copricapo da carabiniere in testa, allora sì che lo avrebbero guardato tutti come fosse un santo, allora sì che sarebbe stato rispettato e ben voluto, molto più di un indiano. Allora avrebbe sicuramente permesso a quella bella ragazza di superare il confine passando per la porta principale, con tanto di omaggi.
«Se non è troppo… potrei provarlo per qualche secondo?»
Dal sorriso che dona il carabiniere, sembrerebbe esser proprio una brava persona. Ecco che se lo toglie bonariamente. «Con piacere, mio caro… ti piace eh? Questa è la mia forza… dona fierezza, eleganza.»
Al villaggio, nel suo Paese, le uniche volte in cui si sentiva forte e si concedeva una camminata fiera, da bambino, era quando si dirigeva verso il muro di confine con l’India… fingeva che ci fosse una porta, sognava di possederne la chiave e di avercela in tasca – sognava anche che la tasca non fosse bucata, ma solo per non perdere la chiave. Non riusciva mai ad avvicinarsi troppo perché puntualmente qualcuno gridava o addirittura lo prendeva di peso e velocemente lo riportava indietro… due schiaffi non glieli levava nessuno, arrivato a quel punto. «Vuoi farti bastonare dalle guardie indiane?» Quali bastoni? Quali guardie? Non si sa.
Jahir è cresciuto, è un uomo, è un bengalese – che a Roma chiamano bangladino, anche questa parola lo fa sempre molto ridere – che ce l’ha fatta a superare quel confine, non senza il prezioso aiuto del bianco turbante. Un indiano il bastone non lo userebbe mai per punire qualcuno.
Che onore, sta per indossare un nuovo, potente, copricapo. Non sarà un turbante, ma non è niente male. Dev’essere una questione di fortuna. C’è chi nasce indiano, chi carabiniere. Chi nasce con un copricapo e chi no… certo poi c’è anche chi se lo ritrova per la via – botta di culo.
Questo cappello, va detto, non lo porta al di là di alcun muro, con questo cappello tutto è chiaro, non vi sono ostacoli. La rigidezza del materiale rende spigoloso persino il suo sguardo. Se avesse avuto questo cappello avrebbe potuto sporgersi a guardare quella ragazza… quella al villaggio. Avrebbe potuto seguirne le vicende una volta raggiunto il suolo indiano. Avrebbe potuto accompagnarla. Avrebbe potuto accompagnare e proteggere quella ragazza, perché alle persone belle accadono solo cose belle; questo insegnano i fiori.
Se avesse avuto questo cappello nessuno al suo villaggio avrebbe temuto il muro di confine. Nessuno sarebbe stato bastonato, nessun bambino sarebbe stato punito per essersi avvicinato troppo alle pietre. Quella ragazza sarebbe stata scortata da lui, dal suo sguardo possente e schermato dalla visiera.
I carabinieri sono quasi come gli indiani, solo che i carabinieri hanno più potere e forza ed è quasi sicuramente merito di questo copricapo; ne è convito, ne riesce a sentire l’impeto, riesce a sentire l’altezza che raggiungerebbe il suo mento se questo cappello fosse davvero suo. Con questo cappello, quella ragazza l’avrebbe potuta seguire e aiutare nel caso fosse servito, l’avrebbe potuta accompagnare verso un mondo migliore: chissà, forse l’avrebbe potuta anche amare ricevendone ammirazione e affetto, lealtà.
Di colpo un grido; un grido di donna. No, un ricordo. Forse aveva ragione sua madre, aveva ragione anche quel tale che sferzava schiaffi sul suo culo. Forse le guardie non urlavano dallo stupore nel vedere quella santa meravigliosa. Forse quella giovane non riuscì a disarmare le guardie. Forse quel fiore sano e vivace è appassito… quel giorno. Inutile pensare a ciò che non si può conoscere. Certamente se avesse avuto quel cappello avrebbe potuto salvarla, questo è l’importante, no?
Jahir non sorride più. Forse quel che c’era dall’altra parte del muro non era poi gran cosa… anzi. Non c’è molto altro da fare se non riconsegnare cortesemente il copricapo al legittimo proprietario.
«Grazie tante.»
Seduto a terra Jahir accende il tablet ben stretto in mano… e comincia a passare in rassegna quelle splendide foto, lasciandosi stordire dalla casualità di quei colori. I fiori, i fiori sì che sono brave persone.
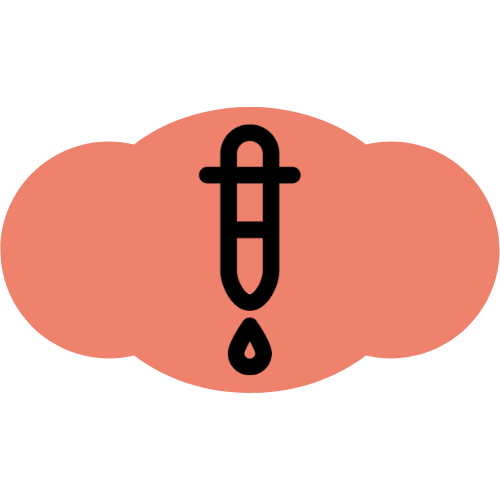 Gianmarco Di Traglia è nato a Roma nel 1994. Regista e sceneggiatore in erba. Fallito prima di emergere? Si vedrà. Tra il 2018 e il 2020 scrive e dirige i cortometraggi Il bambino prodigio, Pâtisserie de jeunesse e Servi servorum dei. Dal 2016 lavora in produzione e redazione per svariati programmi televisivi. Attualmente è nella produzione di Ottoemezzo per La7. Autore radiofonico per Radio Rock.
Gianmarco Di Traglia è nato a Roma nel 1994. Regista e sceneggiatore in erba. Fallito prima di emergere? Si vedrà. Tra il 2018 e il 2020 scrive e dirige i cortometraggi Il bambino prodigio, Pâtisserie de jeunesse e Servi servorum dei. Dal 2016 lavora in produzione e redazione per svariati programmi televisivi. Attualmente è nella produzione di Ottoemezzo per La7. Autore radiofonico per Radio Rock.
